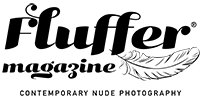In occasione dell’inaugurazione della mostra di Yashima Mishto presso la galleria MAC – Miradoli Arte Contemporanea di Milano, il 3 ottobre, vi proponiamo una piccola anticipazione del suo libro fotografico LIFE OF A SINGULARITY. Le fotografie qui raccolte raccontano, tramite uno stile onirico e semplice, il complesso rapporto dell’erotismo del singolo con la censura imposta dalla società. Attraverso questi suoi ritratti sensuali e spesso al limite dell’osceno, Yashima Mishto racconta se stesso forse ancora più esplicitamente di quanto abbia fatto nell’intervista che qui di seguito vi proponiamo (a cura di Virginia Marchione). L’esposizione LIFE OF A SINGULARITY terminerà il 24 ottobre 2014.

Vivi e lavori a Berlino dal 2003, fotografi dal 1994 ma non sei tedesco di origine. Qual è la tua storia e come mai hai deciso di trasferirti?
Mi sono avvicinato alla fotografia da adolescente e prima di diventare maggiorenne ho iniziato a stampare le mie foto nello sgabuzzino di casa dei miei con un ingranditore DURST F30. Come penso tutti coloro che stampano, ricordo ancora la profonda sorpresa quando vidi per la prima volta l’immagine apparire sul foglio immerso nel liquido si sviluppo. Come un’apparizione.
Ora lavoro con un DURST M700, nella camera oscura del mio studio a Berlino. Tante cose sono cambiate da quando mi sono trasferito in questa città che nonostante abbia perso con gli anni un po’ del suo trasandato splendore, rimane un luogo ove è facile vivere e che ti lascia i tuoi spazi. Dieci anni fa abbandonai progressivamente l’Italia affamato di vita multietnica e internazionale. La trovai a Berlino, e forse per questo il mio tedesco è ancora indecente.

Nel 2002 sei diventato una donna, poi nuovamente uomo nel 2007. Ci parli di queste trasformazioni?
Tutto nacque da una delle mie prima personali, a Berlino, in un centro culturale russo nel 2002. La curatrice dell’area culturale del circolo mi fece la simpatica sorpresa di boicottarmi la mostra il giorno dell’inaugurazione con le foto già appese ai muri, dichiarando che era rimasta offesa in quanto donna dalle mie foto, nonostante durante il mese di preparazione tale sentimento non fosse stato manifestato. A stento non le misi le mani addosso. Da quel giorno però decisi che Yashima Mishto era donna. Alle mostre amiche o modelle delle mie foto impersonavano Yashima. E tutto filava liscio, il pubblico era felice, gli uomini gongolavano, le donne scoprivano una certa intimità con le foto e la fotografa.
Eppure le foto erano le medesime di quando Yashima ero io.
La cosa comunque non mi dispiaceva. In generale mi trovo molto meglio dietro l’obbiettivo che di fronte. Ma tale sciarada aveva problemi intrinsechi dato che le “temporaneamente Yashima” non potevano essere presenti sempre e in città o stati lontani tra loro.
Dopo 5 anni decisi di tornare ad essere Yashima. Da allora ho collaborato con gallerie forse più adatte ai temi trattati nei mie progetti e i disagi si sono attenuati anche se rammento ancora quello schizzo di sangue con cui deturparono una gigantografia della foto “self-contained woman” 6 anni fa all’AB Project Gallery (Berlino).
Nonostante ritragga spesso donne, nei miei progetti non faccio discriminazioni di sesso. Sono persone, non uomini e donne, quelle che si mettono a nudo di fronte alla mia camera. Perciò, le contestazioni femministe di allora e in parte ancora d’oggi mi sono sempre sembrate basate su preconcetti.

Ho letto che collabori con università e ONG e sei molto attivo su progetti legati alla censura e alla discriminazione di genere, tutte attività direttamente collegate alla tua ricerca. Di che tipo di progetti si tratta?
I progetti con l’Università e ONG sono ormai datati. Non escludo di riprenderli in mano, in particolare un progetto sui meccanismi di categorizzazione a cui tenevo molto ma che non riuscii mai a esporre.
Al contrario, viva e vibrante è la costante lotta contro la censura. In questi giorni i telegiornali sono imbottiti di scene di morte e violenza, dall’ennesima invasione del territorio palestinese da parte di Israele ai cadaveri di olandesi in vacanza dispersi nei prati ucraini. Perché questo sia adatto al pubblico, anche minorenne, e un ritratto di donna che mostra la propria vagina non lo sia è stato per me sempre un mistero. Per favore non fraintendermi, con questo voglio dire che vorrei poter sfogliare senza problemi in un caffè un libro di James Nachtwey come uno di Gilles Berquet.
Ritieni quindi che il tuo stesso modo di fare fotografia sia un ribellarsi alla censura?
Nella società d’oggi, censuriamo e ci censuriamo. In questo costante processo limitante, passa il tempo e ci ritroviamo alla fine di una vita con rimpianti e desideri mai realizzati, o realizzati solo attraverso altri, che siano attrici cinematografiche o amiche “molto allegre”. Nei mie progetti i modelli/e si disinibiscono progressivamente, acquistando dimestichezza con se stessi e le proprie corporeità. Penso che ciò porti ad una equilibrata accettazione di sé e degli altri e conseguentemente a un rifiuto della censura e dell’auto censura. Lo stesso processo avviene talvolta nello spettatore che trovando un legame tra sè e la foto non ne nega la dignità intrinseca riconoscendogli quindi il diritto ad essere esposta, mostrata. Il diritto di essere, pubblicamente.


I reportage, invece, come si inseriscono all’interno della tua produzione?
Alcune settimane fa, ho rimesso mano ai negativi del mio primo viaggio in India nel 2002 e sono rimasto sorpreso dalla bellezza di alcuni scatti. Non per mie doti, intendiamoci, ma per la intrinseca grandiosità di quella terra e degli esseri che la animano. I miei reportage, però, non si sono mai evoluti da mere documentazioni di viaggio, dagherrotipi talvolta crudeli scattati da un vagabondo. Continuo a produrre fotografie che piacciono, ma nei reportage non sono io la voce narrante. Almeno fino ad ora.
La mia produzione erotica invece ha fatto un salto rispetto alla mera documentazione. Forse per la semplicità dei soggetti, poche linee soggetti ben identificati, forse la tensione delle modelle e modelli che percepisco, nell’atto di mostrarsi a me come un pasto nudo. Non so perché, ma nelle foto erotiche ho trovato la necessità di ricercare, sia spingendo i soggetti ad abbandonarsi ma anche, e forse sopratutto, sperimentando tecniche di stampa e di scatto, estrapolando il soggetto dal hic et nunc per dargli una valenza più intangibile. Facendolo diventare una fantasia, il frammento di un sogno appena svegli.

Come scegli i tuoi modelli e le tue modelle?
Capita di incontrarli. A volte mi cercano loro.
E’ importante sottolineare che con i modelli/e ho rigorosamente un rapporto “amatoriale”. Ho vari lavori fatti con modelle professioniste o prostitute, per esempio, ma sono sempre stati realizzati su una base puramente personale, “amatoriale” appunto. I miei sono ritratti. Talvolta ritratti cinici, che mettono a nudo aspetti singolari o grotteschi dei soggetti. Difficile quindi che vadano a buon fine se la persona è motivata dalla pecunia nel posare di fronte a me.
Una delle cose che metto in chiaro fin dall’inizio con i modelli/e è che dagli shootings salteranno fuori alcune foto “aggraziate” come vogliono loro, a patto però che non nascondano quell’essere “twisted”. Le persone sono generalmente felici, alla fine del percorso, vedendo fissata su carta una varietà inaspettata della loro identità che spesso neppure conoscevano. Quando succede, i soggetti delle fotografie sono stupiti nel rivedersi ritratti in atteggiamenti così intimi.

Non hai mai incontrato difficoltà da parte dei modelli/e nel permetterti di’esibire poi pubblicamente questi loro scatti così intimi?
Ovviamente, rispetto il pudore legato al mostrare tali intimità a un pubblico in gallerie o pubblicazioni artistiche. Ma le persone sono generalmente (e inaspettatamente) rilassate da questo punto di vista, dopo essersi viste incorniciate e appesa ad un muro. Infatti, ho spesso la sensazione che in realtà io sia solo uno strumento che i modelli/e utilizzano per liberarsi dai veli di autocensura in cui si sono avvolti, imbalsamati. Nel mio tentativo di combattere l’autocensura in realtà trovo spesso nei modelli/e un guerriero che non attendeva altro che essere liberato.
E’ un misto di orgoglio, vanità e pudore che scintilla nelle pupille di una donna di fronte ad una propria foto oscena esposta in una galleria ad altre persone che guardano la foto senza riconoscerla. La sua voce interiore che le dice: sono io, sono io!
A Marzo 2014 hai presentato la tua personale “Life of a Singularity”a Berlino e l’omonimo libro. Questo progetto rappresenta un po’ una metafora dei molteplici aspetti interiori che l’individuo – per timore di preconcetti esterni – tende a celare. L’erotismo è una chiave per mettere a nudo l’anima?
Ho lavorato a “Life of a Singularity” per due – tre anni, che non sono diventati molti di più grazie all’impagabile aiuto di Jule Pasolini per lo sviluppo del progetto ed a JNP Books e Alberto dell’Acqua per la stampa del libro. E’ stato per la mia produzione un momento importante, forse il più importante fino ad ora, perché in questo progetto ho avuto la possibilità di sviluppare un concetto tramite una narrazione fatta di immagini. Tante immagini.
In una mostra personale ho mediamente a disposizione 15-20 fotografie. Nel libro invece ce ne sono un centinaio. Con cento parole si possono spiegare i contorni dell’idea invece che soltanto accennarne le forme.
E il tema di questo progetto è un archetipo che come tale tocca molti di noi, se non tutti.
“Life of a Singularity” tratta il tema della diversità, è una parabola dell’essere unico che vive dentro noi, diverso da tutto il resto del mondo. La diversità tra il mondo e la nostra singolarità produce attriti, se non dolori e sconforto. Nella parabola del progetto questo essere è un individuo “diverso” che per affrontare il mondo inizialmente tenta di camuffarsi in altro, nascondersi (Mimesis), poi prova a curarsi entrando in una clinica psichiatrica (The Clinic) ove la sua diversità è definita come “patologia” assieme a quelle di tanti altri e come tale viene trattata (ma non curata). Infine il protagonista accetta la propria diversità, se ne fa vanto e la utilizza per lavorare in un circo (The Circus). La narrazione avviene tramite soggetti nudi a simboleggiare la nudità del nostro essere di fronte al mondo circostante. L’erotismo in tal caso è quindi un simbolo dell’anima nuda piuttosto che una chiave per denudarla.
Nella narrazione ci ho messo anche alcuni spunti autobiografici, tra cui anche un irriverente umorismo che alleggerisce alcune scene abbastanza forti. E’ un libro che a tratti fa ridere, se si ha un incensurato dark humour.

Scatti solo in analogico?
Rigorosamente. Stampo personalmente ogni foto. Nel mio studio o in alcuni laboratori quando voglio stampare in grande formato. Solo in bianco e nero.
Scatto con una Olympus OM-1, con la quale ho iniziato a fotografare, e in medio formato con una Rollei 2.8 o una Mamiya R67.
Se mi avvicinassi ora alla fotografia userei probabilmente il digitale ma l’analogico a un sapore diverso, ha come un’anima propria che quando stampi si mostra, emerge, prende corpo. L’analogico è materico.
Le mie foto sono materiche.
A quale progetto stai lavorando, o stai pensando di lavorare, per il futuro?
“Life of a Singularity “è un progetto in pieno sviluppo. La pubblicazione del libro all’inizio di quest’anno è stata una summa del lavoro fatto nel corso degli anni ma non ne è la fine. E’ più una sorta di Bigniami che lo spettatore può portarsi dietro per comprendere meglio il progetto stesso. Nelle gallerie che ospitano questo viaggio in itinere, come ad esempio MAC Gallery (Milano) in Ottobre o la Maurice Einhardt Neu Gallery (London) a Novembre, verranno esposte varie inedite fotografie narranti le tre sezioni di questo mio studio. Perché il libro è stato una sorta di catalizzatore che ha facilitato l’estroflessione della propria singolarità. Mi trovo quindi sempre più persone che si identificano nell’idea e ne vogliono far parte. Penso che “Life of a Singularity” darà frutti ancora per mesi e mesi. E’ una sorta di vaso di Pandora.
Ovviamente ho altre idee in cantiere, un secondo libro per esempio, il titolo preliminare è “Doll Metamorphosis”, in collaborazione con una disegnatrice con cui collaboro a Berlino. Ma è ancora troppo presto per parlarne.
I tuoi personaggi si ispirano ad un’icona (o a delle icone)?
No, non direi. Come detto, lavoro maggiormente sulle singolarità, che come tali non possono richiamarsi ad icone.
Chi o cosa non vorresti dover mai fotografare?
Onestamente al momento non mi viene in mente nulla.